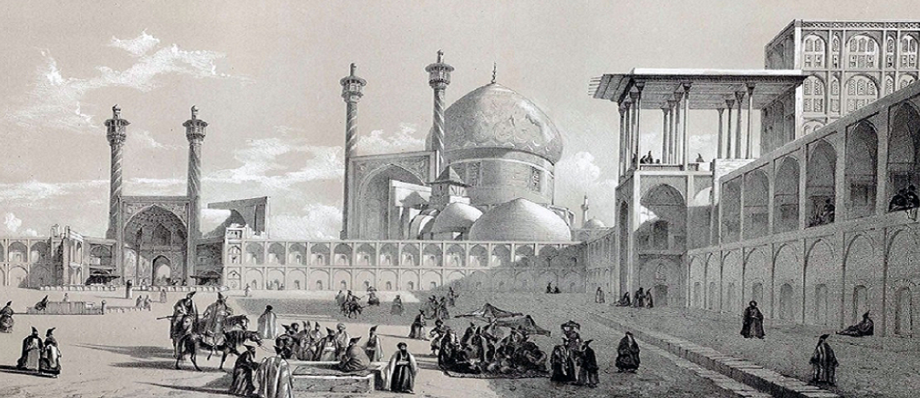
Appunti sul vicino Oriente e altri scritti politici
Iran – USA: uno scambio di prigionieri ed alcune altre considerazioni
Prologo: L’Iran ha passato senza troppi traumi il primo anniversario della morte della giovane Mahsa Amini. Le autorità hanno fatto il possibile per impedire manifestazioni di protesta. Qualcuno è tornato in piazza ed a Tehran, come in alcuni centri curdi, si è aperto il fuoco mentre ad Isfahan vi sono stati una novantina di arresti. Il regime si sta impegnando al massimo per reprimere il dissenso, facilitato in questo dalla diffusione della tecnologia digitale in grado di sorvegliare ed individuare chi si muove per le strade. Il paese resta tuttavia scontento e la situazione interna non è certo facile.
Complicata anche la situazione negli Stati Uniti in vista delle imminenti elezioni presidenziali. Due terzi degli americani sono contrari sia alla ricandidatura dell’attuale presidente Biden che a quella del suo rivale Trump. Si è anche aperto un dibattito sull’età anagrafica dei candidati mentre la maggioranza degli elettori moderati dà l’impressione di non identificarsi in nessun partito. Vi è intanto anche il rischio che lo stato federale possa smettere di pagare i suoi conti con la conseguente cessazione delle attività della Pubblica amministrazione. Il paese si interroga e rivela tutte le sue divisioni.
Un accordo di scambio: Tramite i buoni uffici del Qatar e dopo alcuni mesi di non facili negoziati, tra Tehran e Washington si è arrivati ad un accordo che si è tradotto nella liberazione di dieci prigionieri, cinque dei quali erano detenuti negli Stati Uniti e cinque in Iran. Questi ultimi avevano anche la cittadinanza americana che le autorità di Tehran avevano rifiutato di riconoscere. Erano stati arrestati con l’accusa di spionaggio e cospirazione a danno della Repubblica Islamica.
Quanto agli iraniani liberati, generalmente parlando erano stati condannati per traffico di materiale tecnologico utile all’industria militare ed esportazione illegale di attrezzature da laboratorio. Di questi, due hanno deciso di rientrare nel loro Paese, altri due hanno preferito rimanere negli Stati Uniti e l’ultimo ha dichiarato di voler raggiungere dei parenti che oggi vivono sul continente americano.
Oltre a liberare i cinque cittadini iraniani, Washington ha sbloccato 6 miliardi di dollari provenienti da vendite di petrolio alla Corea del Sud e successivamente confiscati. Una volta trasferiti su un conto particolare in Qatar, questi sarebbero stati poi versati su sei diverse banche iraniane.
Sia il presidente Biden che il Segretario di Stato Blinken hanno accolto la notizia con sollievo e si sono rallegrati per il buon esito dell’operazione. Gli avversari di parte repubblicana non hanno esitato a cogliere l’occasione per accusare l’amministrazione di aver pagato un riscatto. Di fatto così non è stato e la Casa Bianca può vantarsi di aver ottenuto un successo, non avendo sborsato un centesimo di suo per portare a termine questa trattativa.
Come abbiamo visto, si è limitata a scongelare degli averi appartenenti di fatto all’Iran. Per sottolineare di aver comunque mantenuto un atteggiamento di rigore, lo stesso presidente Biden ha fatto sapere che in caso di ulteriori provocazioni continuerà a sanzionare la Repubblica Islamica, aggiungendo che vigilerà su come verranno spesi questi soldi indicando inoltre che potranno essere impiegati unicamente a scopi umanitari per l’acquisto di beni necessari alla popolazione. Ha poi sanzionato l’ex-presidente Ahmadinejad ed il ministro dell’Informazione.
Per quel che riguarda il pubblico americano, la notizia è passata quasi inosservata e la reazione si è rivelata ben meno marcata di quella dell’amministrazione. In questa faccenda da parte di Tehran è stato compiuto indubbiamente uno sforzo e non ritengo improbabile che in futuro si possa andare al di là di qualche semplice scambio, dato che in Medio Oriente si stanno attualmente muovendo diverse situazioni.
Un contesto in movimento: Ho sempre ritenuto che in politica estera i simboli fossero importanti. Merita dunque qualche rilievo l’arrivo a Tehran di Cristiano Ronaldo insieme alla squadra saudita dell’al-Nassr. Erano sbarcati in Iran per sfidare il Persepolis nel contesto della Champions League asiatica. Il campione portoghese è stato accolto trionfalmente da una folla entusiasta che ha preso d’assalto ed inseguito i pullman con a bordo i giocatori fino in hotel. E’ stata tale l’euforia che si è dovuto annullare l’allenamento di rifinitura prima della partita.
Poco dopo il presidente Raisi si è recato all’Assemblea generale dell’ONU, dove è salito sul podio per un breve intervento. Ha chiesto agli Stati Uniti di revocare le sanzioni che non si sono rivelate all’altezza dei risultati sperati. Si è poi dichiarato pronto a sostenere un accordo di pace riguardo la guerra in Ucraina. E’ importante sottolineare che questa volta si è presentato anche come parte del gruppo dei BRICS, nel quale sono stati ammessi sia l’Arabia Saudita che gli Emirati Arabi Uniti. Questo lascia sperare alla Segreteria generale delle Nazioni Unite che si possa giungere ad un calo delle tensioni. Non è infatti un caso che Tehran abbia ripreso il dialogo con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica e non abbia più superato il 60% di arricchimento dell’uranio.
Va ricordato che nel 2018 per volontà del presidente Trump gli americani erano usciti unilateralmente dall’accordo sul nucleare quando, di fatto, l’Iran lo stava rispettando. E’ poi stato ricoperto di sanzioni mentre gli europei non hanno aperto bocca. L’accordo tuttavia ancora esiste, ma va detto che Stati Uniti ed Europa temono tutt’ora che l’Iran voglia dotarsi dell’arma atomica. In risposta, la Repubblica Islamica non ha esitato a giocare la carta dei rapporti di forza e prendere degli ostaggi da usare poi nel modo più conveniente.
Questo scambio di prigionieri è certamente stato un primo passo diplomatico al quale potrebbero seguirne altri in vista di un allentamento delle tensioni e un miglioramento nei rapporti tra le due nazioni. La speranza è che in un eventuale futuro si possa arrivare ad una ripresa dei negoziati sul nucleare. Ad oggi non si può dire molto di più perché ben poco si sa: penso tuttavia che tra le due parti siano in corso delle trattative sotterranee che le vede con tutta probabilità continuare un loro dialogo. Questo dovrebbe dare una lezione agli europei che non si mostrano capaci di molto.
Che in Medio Oriente le cose si stiano muovendo lo dimostra anche il recente viaggio del premier israeliano Netanyahu a Washington, la visita in Arabia Saudita del suo ministro del Turismo e l’invio per la prima volta in 30 anni di una delegazione saudita nei Territori palestinesi in Cisgiordania al fine di rassicurare questi ultimi che Riyadh rimane al loro fianco.
Considerazioni finali: Molte cose stanno dunque bollendo in pentola ed un eventuale accordo tripartito tra Stati Uniti, Israele ed Arabia Saudita non potrà non tener conto anche dell’Iran. Come evolveranno le cose e quale piega prenderanno gli eventi lo si saprà solo dopo le elezioni presidenziali americane dell’anno prossimo. Va ricordato che per rientrare nell’accordo sul nucleare il presidente, qualunque esso sia, avrà bisogno del dell’approvazione del Congresso e questo è vero per qualsiasi altra decisione importante in politica estera.
In attesa di sapere quale sarà il nuovo Presidente degli Stati Uniti è probabile ci si possa aspettare un certo rallentamento delle attività diplomatiche. La Storia comunque ha un suo percorso e potrebbero nascere delle sorprese. In Medio Oriente sono ancora aperte molte questioni e vi è dunque molto di detto e di non detto. Nel frattempo, non nascondiamolo, di fronte alla complessità delle partite in corso, ognuno spingerà per ottenere il massimo.
Pubblicato sul sito di Politica Insieme
2025-14-03 - Una trattativa difficile-tr[...]
Documento Microsoft Word [167.0 KB]
2024-03-20 - Macron s'en va en guerre ed[...]
Documento Microsoft Word [37.3 KB]
Documento Microsoft Word [65.5 KB]
2014 - Il ruolo dell'URSS nella nascita[...]
Documento Microsoft Word [42.0 KB]
2023 - 10.20.23 - Avvisaglie di una camp[...]
Documento Microsoft Word [24.4 KB]
2023 - 07.08.23 - L'Arabia Saudita e la [...]
Documento Microsoft Word [111.0 KB]
Documento Microsoft Word [49.5 KB]
2022 - 12.16.22 - Le elezioni di medio t[...]
Documento Microsoft Word [41.5 KB]
2022 - 12.09.22 - Israele - Mai così a d[...]
Documento Microsoft Word [105.0 KB]
2022 - 07.18.22 - Alcune riflessioni sul[...]
Documento Microsoft Word [101.1 KB]
2021 - 04.19.21 - Un racconto di due cit[...]
Documento Microsoft Word [28.9 KB]
2021 - 04.10.21 - Un trasloco di mummie [...]
Documento Microsoft Word [24.6 KB]
2021 - 04.01.21 - Biden Putin e Cina - U[...]
Documento Microsoft Word [28.0 KB]
(Pubblicato il 26 Marzo sul sito Politica Insieme)
2021 - 03.25.21 - Solo in Israele- appun[...]
Documento Microsoft Word [20.6 KB]
(Pubblicato il 18 Marzo sul sito Politica Insieme)
2021 - 03.12.21 - Il viaggio storico di [...]
Documento Microsoft Word [33.2 KB]
2021 - 01.25.21 - Il rientro di Navalny [...]
Documento Microsoft Word [62.5 KB]
2021 - 01.20.21 - La Tunisia e l'Egitto [...]
Documento Microsoft Word [31.9 KB]
2020 - 12.18.20 - Alcune note sulle elez[...]
Documento Microsoft Word [42.8 KB]
(Pubblicato il 9 Aprile sul sito Politica insieme)
2020 - 11.30.20 - Nagorno Karabakh - Un [...]
Documento Microsoft Word [30.9 KB]
(Pubblicato il 24 Marzo sul sito Politica Insieme)
2020 - 11.16.20 - Un mondo che cambia e [...]
Documento Microsoft Word [44.5 KB]
2020 - 10.10.20 Nagorno Karabakh - la ri[...]
Documento Microsoft Word [52.0 KB]
09.10.2020 - Libano agonia di un paese e[...]
Documento Microsoft Word [89.5 KB]
2020 - 08.07.20 - A proposito di un deli[...]
Documento Microsoft Word [81.5 KB]
2020 - 07.14.20 - Una nuova legge per Ho[...]
Documento Microsoft Word [68.5 KB]
2020 - 07.07.20 - La riforma costituzion[...]
Documento Microsoft Word [79.0 KB]
2020 - 06.01.20 - I francesi nel Sahel.d[...]
Documento Microsoft Word [92.0 KB]
2020 - 06.01.20 - Coronavirus e morte ne[...]
Documento Microsoft Word [146.5 KB]
2020 - 05.28.20 - Le visioni palestinesi[...]
Documento Microsoft Word [97.0 KB]
del Ministero degli Affari Esteri
Proposta ex art. 22 dello Statuto origin[...]
Documento Microsoft Word [34.0 KB]
2020 - 01.01.20 - Hong Kong - un'ulterio[...]
Documento Microsoft Word [96.0 KB]
2019 - 12.01.19 - Iran perché è necessar[...]
Documento Microsoft Word [89.0 KB]
2019 - 10.22.19 - Hong Kong, Algeria e S[...]
Documento Microsoft Word [156.0 KB]
Testo della Conferenza del 22 Ottobre 2019
2019 - 10.22.19 - Conflitto con la mode[...]
Documento Microsoft Word [121.5 KB]
2019 - 09.01.19 - Jammu-Kashmir - Un' au[...]
Documento Microsoft Word [61.0 KB]
2019.09.03 - Groenlandia - Una strana tr[...]
Documento Microsoft Word [40.0 KB]
2019 - 07.15.19 - Stati Uniti e Iran obb[...]
Documento Microsoft Word [48.5 KB]
2019 - 06.24.19 - Incidenti nel Golfo di[...]
Documento Microsoft Word [56.0 KB]
(Nota: Questo testo è alla base di una conferenza tenuta il 10 Aprile 2019 presso la Casa dell'Aviatore)
2019 -04.11.19 Può l’Islam considerarsi [...]
Documento Microsoft Word [104.5 KB]
2019 - 01.10.19 - La decisione del ritir[...]
Documento Microsoft Word [66.5 KB]
2019. 01.07.19 - I rapporti tesi tra Rus[...]
Documento Microsoft Word [55.0 KB]
2019 - 01.01.19 - Stoccolma - un primo p[...]
Documento Microsoft Word [33.0 KB]
(Nota: Parte di questo testo è stato pubblicato nel numero 187 - Inverno 2018 - della Rivista Affari Esteri)
2018 - 12.10.18 - Una breve storia dell'[...]
Documento Microsoft Word [259.5 KB]
2018 - 11.01.18 - Due risoluzioni da non[...]
Documento Microsoft Word [103.0 KB]
(Nota: Pubblicato nel numero 186 - Autunno 2018 - della Rivista Affari Esteri)
2018 - 09.01.18 - La scommessa di Mohame[...]
Documento Microsoft Word [83.5 KB]
2018 - 06.10.18 - Il viaggio in Europa d[...]
Documento Microsoft Word [29.5 KB]
(Nota: Pubblicato nel numero 184 - Primavera 2018 - della Rivista Affari Esteri)
2018 - 03.14.18 - Alcune considerazioni [...]
Documento Microsoft Word [94.0 KB]
2018 - 03.12.18 - Uno sguardo sull'attiv[...]
Documento Microsoft Word [39.0 KB]
2017 - 12.14.17 - Il caso Hariri e la co[...]
Documento Microsoft Word [70.5 KB]
2017 - 12.10.17 - Lo strano viaggio di E[...]
Documento Adobe Acrobat [68.9 KB]
(Nota: pubblicato nel numero 183 -Inverno 2018 - della Rivista Affari Esteri)
2017 - 10.18.17 - Sul problema nucleare [...]
Documento Microsoft Word [20.9 KB]
(Nota: pubblicato nel numero 182 - Autunno 2017 - della Rivista Affari Esteri)
2017 - 06.25.17 - Distruzione della Mosc[...]
Documento Adobe Acrobat [90.2 KB]
(Nota: Pubblicato nel numero 181 - Estate 2017 - della Rivista Affari Esteri)
2017 - 05.23.17 - Le elezioni iraniane.p[...]
Documento Adobe Acrobat [103.0 KB]
(Nota: Pubblicato nel numero 181 - Estate 2017 - della Rivista Affari Esteri)
2017 - 04.28.17 - Verso una nuova Turchi[...]
Documento Adobe Acrobat [100.9 KB]
2017 - 04.24.17 - Tensioni tra Stati Uni[...]
Documento Adobe Acrobat [110.5 KB]
2017 - 04.15.17 - La madre di tutte le b[...]
Documento Adobe Acrobat [78.6 KB]
2017 - 04.10.17 - I missili di Trump col[...]
Documento Adobe Acrobat [111.5 KB]
2017 - 04.08.17 - La gioventu' russa sce[...]
Documento Adobe Acrobat [80.4 KB]
2017 - 03.31.17 - L'ultimo attacco aereo[...]
Documento Adobe Acrobat [68.2 KB]
2017 - 03.26.17 - Un commento sui 60 ann[...]
Documento Adobe Acrobat [96.9 KB]
(Nota: Pubblicato nel numero 182 - Autunno 2017 - della Rivista Affari Esteri)
2017 - 03.12.17 - Distruzioni di Palmir[...]
Documento Adobe Acrobat [102.5 KB]
2017 - 02.23.17 - Ipotesi di un futuro p[...]
Documento Adobe Acrobat [94.3 KB]
2015 - 12.24.15 - Due dichiarazioni su P[...]
Documento Microsoft Word [14.0 KB]
2016 - 12.31.16 - Sulla nomina di un nuo[...]
Documento Microsoft Word [36.0 KB]
2016 - 12.06.16 - A proposito del Refere[...]
Documento Microsoft Word [30.0 KB]
2016 - 12.05.16 - I simpatizzanti di Tru[...]
Documento Microsoft Word [26.9 KB]
2016 - 12.03.16 - Elezioni americane - L[...]
Documento Microsoft Word [37.5 KB]
(Nota: Pubblicato nel numero 179 - Inverno 2017 - della Rivista Affari Esteri)
2016 - 12.01.16 - Conflitto con la mode[...]
Documento Microsoft Word [122.5 KB]
2016 - 11.11.16 - Parigi conclude l'oper[...]
Documento Microsoft Word [14.0 KB]
2016 - 05.15.16 - Le elezioni in America[...]
Documento Microsoft Word [46.5 KB]
2016 - 03.07.16 - Le elezioni in America[...]
Documento Microsoft Word [43.5 KB]
Documento Microsoft Word [22.0 KB]
2016 - 02.04.16 - Le nuove tensioni in P[...]
Documento Microsoft Word [19.0 KB]
2016 - 01.30.16 - L' Egitto a cinque an[...]
Documento Microsoft Word [18.0 KB]
(Nota: pubblicato nel numero 177 - Estate 2016 - della Rivista Affari Esteri)
2016 - 01.28.16 - Il ritorno del Califfa[...]
Documento Microsoft Word [42.0 KB]
(Nota: si tratta di una nuova versione di Brevi considerazioni sull'Isis, modificata e aggiornata per il numero di Gennaio della Rivista Affari Esteri - Anno 2016)
2015 - 11.30.15 - Il vessillo nero dell'[...]
Documento Microsoft Word [31.0 KB]
2015 - 11.30.15 - Il vessillo nero dell'[...]
Documento Microsoft Word [31.0 KB]
2015 - 08.26.15 - Brevi Considerazioni s[...]
Documento Microsoft Word [46.0 KB]
2015 - 08.16.15 - Impressioni sul viaggi[...]
Documento Microsoft Word [28.5 KB]
2015 - 03. 27.15 - Riflessioni sul testo[...]
Documento Microsoft Word [17.5 KB]
2015 - 11.17.15 - E poi verrà il Califf[...]
Documento Microsoft Word [127.0 KB]
(Nota interna per il Partito Repubblicano e spunti di riflessione per il tavolo di politica estera)
2014 - Appunti sul Medio Oriente dal Pr[...]
Documento Microsoft Word [57.0 KB]
(Nota interna per il Partito Repubblicano e spunti di riflessione per il tavolo di politica estera)
2014 - Appunti sul Medio Oriente dal Pr[...]
Documento Microsoft Word [57.0 KB]
2014 - Il ruolo dell'URSS nella nascita [...]
Documento Microsoft Word [28.0 KB]
2011 - 09.29.11 - Articolo per rivista A[...]
Documento Microsoft Word [73.0 KB]